| GLI OBIETTIVI |
Cos'è l'obiettivo?
L'obiettivo è un cilindro al cui interno sono situate una o più
lenti con particolari caratteristiche ottiche.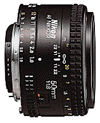
E' sicuramente la parte più importante del corredo fotografico in quanto solo con una buona ottica è possibile ottenere risultati di qualità.
Lo schema costruttivo di un obiettivo, oggi disegnato generalmente al computer, dipende fondamentalmente dalle caratteristiche che si vogliono ottenere in termini di focale, luminosità, risoluzione ecc. Comunque sia, il numero delle lenti che compongono l'ottica non sono un indice della sua qualità.
Ogni ottica ha una serie
di caratteristiche, alcune verificabili direttamente osservando l'obiettivo:
lunghezza
focale, luminosità, messa
a fuoco, diaframmi, tiraggio.
Altre insite nei materiali e nello schema costruttivo dello stesso, non
visibili ad un'osservazione superficiale, relative alla : resa
dell'ottica.
 La
lunghezza focale di un obiettivo, generalmente scritta sul corpo dello
stesso, è un valore che indica la distanza tra il punto centrale
dell'obiettivo (messo a fuoco all'infinito) ed il piano della pellicola
La
lunghezza focale di un obiettivo, generalmente scritta sul corpo dello
stesso, è un valore che indica la distanza tra il punto centrale
dell'obiettivo (messo a fuoco all'infinito) ed il piano della pellicola
Gli obiettivi , relativamente alla lunghezza focale, si dividono in tre grandi categorie :
Per le fotocamere 35mm e' considerato normale un obiettivo di focale 50mm, questo perché la copertura dell'ottica è proporzionale alla grandezza della pellicola. Fotocamere per pellicole di dimensioni maggiori utilizzeranno obiettivi più lunghi per avere lo stesso tipo di copertura.
Le ottiche possono essere
di focale fissa o variabile (ZOOM), quest'ultimi, che grazie alla loro
versatilità e comodità (nonché prezzi sempre più
bassi) hanno invaso il mercato, con il grande vantaggio di passare
gradualmente da una focale all'altra semplicemente girando una ghiera o
con un sistema a 'pompa' (one-touch).
Sul mercato ne esistono di tutti i tipi e con focali che vanno dal 18-50 al 100-500 ed oltre; nonostante la comodità questi obiettivi sono, in genere, scarsamente luminosi ed hanno una resa cromatica e definizione non paragonabile a quella delle focali fisse.
Ogni obiettivo ha inoltre una propria profondità di campo (vedi diaframmi) derivante sia dalla luminosità che dalla lunghezza focale.
Anche se può essere errato parlare di profondità di campo relativamente alla focale è pur vero che questa è direttamente collegata in quanto obiettivi come i grandangolari permettono, a parità di distanza e diaframma, di avere una maggiore profondità di campo di quanto non abbia un teleobiettivo. Di conseguenza la capacità di isolare o 'immergere' un soggetto nell'ambiente circostante è vincolata dall'uso di un'ottica (il tele) od un'altra (grandangolo).
Inoltre ogni focale da una sua ben precisa prospettiva, a parte gli obiettivi normali, che non falsano le prospettive, il grandangolo allontana i piani dell'immagine ed oggetti uguali ma a differenti distanze appaiono con dimensioni diverse (quelli vicini enormi, quelli lontano piccolissimi), dando una sensazione di spazio, il tele li avvicina, li schiaccia, li rende di dimensioni simili, diminuisce la profondità e fa perdere il senso della distanza.
Gli effetti vengono resi al massimo quando con il grandangolo inquadriamo il soggetto molto da vicino, con il tele quando il soggetto e' molto distante.

Ripresa con focale 24 mm |

Ripresa con focale 50 mm (normale) |

Ripresa con focale 200 mm |
La luminosità (o apertura relativa) è l'indicazione della quantità di luce che l'obiettivo lascia passare e corrisponde, normalmente, all'apertura massima di diaframma. Generalmente, infatti, quando non specificato, la luminosità di un'ottica coincide con il diaframma più grande presente.
 La
luminosità di un obiettivo dipende dalla lunghezza focale (più
è lungo maggiore sarà la quantità di luce assorbita)
e dalla grandezza della lente frontale (più è grande, maggiore
sarà la quantità di luce che può entrare). Il calcolo
della luminosità di un'ottica è infatti dato dal diametro
della lente frontale diviso la focale. E' per questo motivo che si parla
di apertura relativa, in quanto la luminosità è data dalla
relazione tra questi due fattori. Questo spiega perché le ottiche
molto luminose hanno delle lenti frontali sproporzionate rispetto le altre
dell'obiettivo.
La
luminosità di un obiettivo dipende dalla lunghezza focale (più
è lungo maggiore sarà la quantità di luce assorbita)
e dalla grandezza della lente frontale (più è grande, maggiore
sarà la quantità di luce che può entrare). Il calcolo
della luminosità di un'ottica è infatti dato dal diametro
della lente frontale diviso la focale. E' per questo motivo che si parla
di apertura relativa, in quanto la luminosità è data dalla
relazione tra questi due fattori. Questo spiega perché le ottiche
molto luminose hanno delle lenti frontali sproporzionate rispetto le altre
dell'obiettivo.
I vantaggi delle ottiche
più luminose (rapporto 1:1,2 , 1:1,4, 1:1,8 ecc.) sono evidenti,
a parità di pellicola permettono tempi di esposizione brevi, ed
a volte di fotografare a mano libera in condizione di luce proibitiva;
di contro (oltre ad un costo molto elevato) possono essere (alla massima
apertura di diaframma) leggermente meno nitidi.
Tutti gli obiettivi hanno una distanza di messa a fuoco minima ed una massima. Mentre tutti (per i 'micro' non e' sempre vero) mettono a fuoco correttamente fino all'infinito (punto oltre il quale tutto e' a fuoco), la minima varia secondo il tipo di ottica ed il tipo di costruzione. In genere è inversamente proporzionale alla lunghezza focale.
Esistono ottiche speciali in grado di mettere a fuoco soggetti fino a 20 cm denominati 'micro' ed usati per scopi scientifici o naturalistici; altri, che permettono messe a fuoco minime con obiettivi di diverse lunghezze focali, vengono definiti (dai costruttori) 'macro' e sono in genere ottiche non specialistiche caratterizzate, però, da una buona versatilità.
Negli ultimi anni si sono
diffusi obiettivi AUTOFOCUS che attraverso sistemi e brevetti differenti
mettono a fuoco il soggetto (nella parte centrale dell'inquadratura) in
modo completamente automatico. Questi obiettivi necessitano (a parte qualche
raro caso) di macchine costruite apposta per il loro utilizzo, hanno costi
più elevati, rispetto a quelli normali, ed una resa non sempre a
livelli professionali.
Il diaframma è un 'iride' meccanico che permette di gestire la quantità di luce che passa attraverso l'obiettivo e di controllare e variare il calcolo di esposizione della pellicola. Infatti, i valori di diaframma, sono calcolati in modo che ad ogni chiusura dello stesso corrisponda un tempo di esposizione doppio a quello necessario precedentemente; per esempio se l'esposizione richiedeva 1/125 di secondo con diaframma 5.6, chiudendo il diaframma ad 8 il tempo sarà di 1/60".
Il diaframma, inoltre, permette il controllo della profondità di campo; non inoltrandoci nelle regole fisiche che riguardano l'ottica, diremo che più è piccolo il diametro del foro attraverso il quale passa la luce maggiore sarà la zona a fuoco davanti e dietro il soggetto inquadrato.
All'atto pratico più è piccolo il diaframma tanto maggiore sarà la zona di messa a fuoco.
La profondità di campo
si può verificare o controllando lo schema presente su quasi tutti
gli obiettivi vicino la messa a fuoco, oppure direttamente nel mirino con
le ottiche o macchine che prevedono questo tipo di controllo.
Il tiraggio e' la distanza
che intercorre tra il piano della pellicola ed il bocchettone di innesto
dell'obiettivo. E' un elemento importante solo quando vogliamo adattare
alla nostra macchina ottiche con attacchi non costruiti specificatamente
per quest'ultima
La qualità di un obiettivo è data da una serie di fattori :
N.d.r. quasi tutti gli obiettivi danno in massimo di se stessi ad aperture di diaframma medie.essere incisivo; Il grado di incisione e' dato dalla correzione di una serie di difetti , aberrazioni , astigmatismo, coma, ecc., che riducono la nitidezza dei riproduzione. cromaticamente corretto; la correzione cromatica migliora la resa dei colori. non avere riflessioni interne; ridurre i più possibile la formazione di veli e macchie di luce. E' evidente soprattutto nei controluce, che mettono a dura prova le prestazioni delle ottiche. distribuire uniformemente la luce; la luce che arriva sul piano della pellicola deve essere il più possibile uniforme, le ottiche di scarsa qualità hanno perdite di luminosità, ai bordi dell'immagine, che arrivano anche ad un step di differenza. non creare distorsioni dell'immagine; la resa deve essere più neutra possibile, non devono esserci (soprattutto ai bordi) distorsioni delle linee.